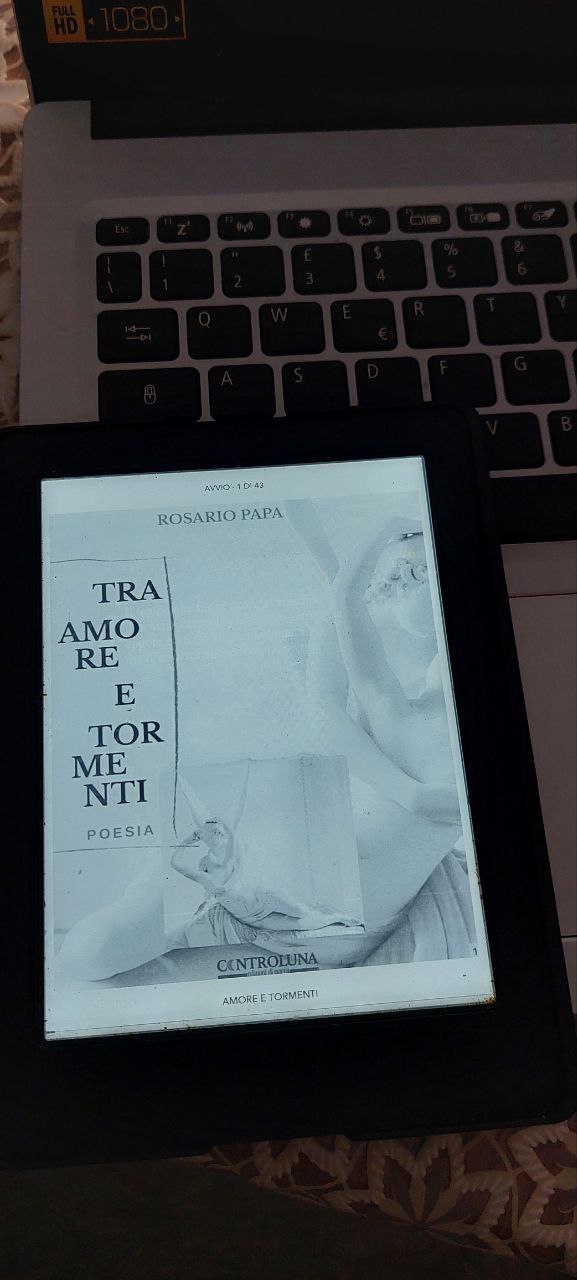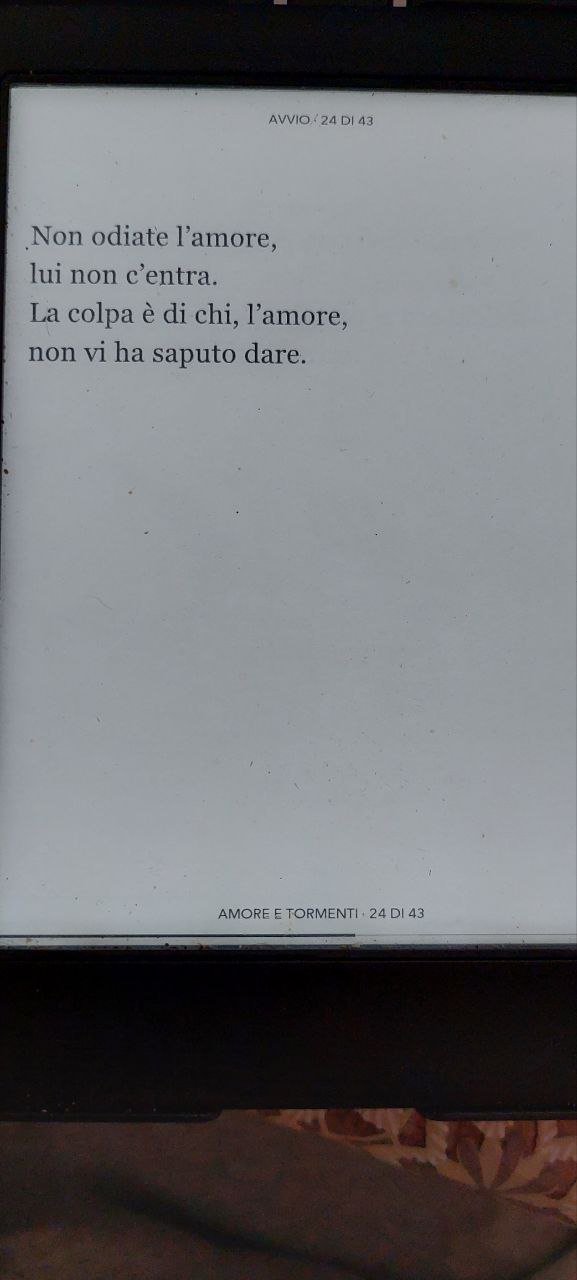25/04/1970
Mia madre era una donna straordinaria. Aveva un cuore generoso, una mente creativa e uno sguardo attento e curioso. Non le piaceva oziare, era un’instancabile lavoratrice. Amava le sfide e la sua famiglia.
Quando mio padre le scrisse di raggiungerlo, lei non esitò a preparare le valigie per andare in America. Era partito poco dopo la mia nascita in cerca di fortuna e mamma non aveva mai smesso di credere in lui. Così ci imbarcammo nella prima nave disponibile, sopportando la mancanza di igiene, il sovraffollamento e la scortesia del personale di bordo. Ero una bambina di cinque anni annoiata e mamma, per distrarsi anche dalla nausea e dalla forte emicrania, aveva cominciato a cantare in dialetto siciliano. La sua voce era forte e intonata, talmente bella da far danzare anche gli altri viaggiatori, donne e bambini italiani che volevano lasciare il paese.
Giunte in America ci sottoposero a diversi controlli medici, alcuni dei quali erano imbarazzanti e troppo invadenti.
L’ultima volta che vidi mio padre non sapevo parlare. Lo conoscevo per mezzo di una foto che lui aveva spedito insieme ai soldi.
Avevo memorizzato i tratti del suo viso ma, quando me lo trovai davanti, notai certi dettagli che la macchina fotografica non poteva acquisire. La persona che mi aveva accolto nel Nuovo Mondo con un abbraccio non era frutto della mia immaginazione: era reale.
Fu disorientante stringere quell’uomo, accorgersi che anche il suo sorriso, come il mio, coinvolgeva tutti i muscoli del volto
In poco tempo cominciai ad abituarmi alla sua presenza nella mia vita. Scoprii che mio padre aveva l’abitudine di alzarsi alle tre del mattino, per guardare l’alba dalla finestra della cucina fumando un sigaro. Cercava sempre di muoversi con delicatezza per non disturbare il nostro sonno, ma ogni mattina, in stato di dormiveglia, sentivo i suoi passi contro il corridoio e percepivo la sua presenza sulla soglia della mia stanza. Non aprivo mai gli occhi, ma lo immaginavo ad osservarmi dormire con un sorriso. Forse, pensando a tutte quelle cose che si era perso della mia infanzia.
Sfortunatamente, l’armonia familiare subì un repentino cambiamento quando mio padre ebbe un incidente sul lavoro. Le fondamenta della casa su cui stava operando non erano stabili, per questo l’infortunio lo costrinse all’inattività e poi alla disoccupazione. Rischiavamo di indebitarci per le cure mediche e di perdere la casa.
Eppure, neanche quando finimmo i risparmi per comprare i beni di prima necessità, la mamma si perse d’animo. Un giorno uscì con l’espediente di comprare dei farmaci per papà e tornò a casa annunciando di avere accettato una proposta di lavoro. Quella sera, mamma e papà discussero tanto: lei desiderava rendersi autonoma e contribuire a risanare la crisi economica in cui ci trovavamo, lui sentiva di essere un peso. Odiava il fatto di non poter tornare a lavorare, avrebbe dovuto occuparsi di ridefinire il balcone di quella casa, invece il ballatoio era crollato sotto i suoi piedi. Così, papà era scivolato nel terrazzino dell’appartamento sotto perdendo i sensi. I soccorsi lo avevano definito un miracolo, nessuno sarebbe sopravvissuto dopo una caduta simile, tuttavia, i medici non sapevano se sarebbe tornato a camminare, né quando.
«Sono io quello che dovrei lavorare, non tu!» gridò quella volta alla mamma.
«Ma tu non puoi, e qualcuno dovrà pur provvedere a pagare tutti questi debiti!» si difese lei. «E poi io voglio lavorare. Non mi hai neppure chiesto di che lavoro si tratta, Giancarlo!»
«Perché non mi interessa. Tu, da donna, devi stare a casa con la bambina. Non devi lavorare.»
«Non abbiamo neanche i soldi per comprare un po’ di farina. Non abbiamo niente!»
«Sono io l’uomo di casa, non tu.»
«Tu non puoi lavorare, io invece posso. Andiamo, Giancarlo! Devo solo cucire delle camicette.»
Alla fine, era riuscita a convincerlo. Così, alle sette del mattino seguente, si presentò al nuovo impiego tornando a casa esausta dodici ore dopo.
«Oh, Giancarlo!» esclamò mia madre, mangiando la zuppa che papà aveva preparato. «Dovresti vedere le macchine da cucire che hanno in fabbrica, sono eccezionali! Riducono il tempo di produzione, e oggi ho realizzato più di venti camicie. Sai, ho anche conosciuto delle donne italiane, ci pensi? Persone che parlano la nostra stessa lingua… Non è fantastico?»
«Sì» fece mio padre, mostrando un sforzato sorriso. «Credo proprio di sì» disse di nuovo con maggiore convinzione.
Il 25 marzo del 1911 mamma si alzò presto per unirsi con me e papà ad ammirare l’alba.
«Buon compleanno, Lucia!» esclamarono all’unisono i miei genitori.
«Abbiamo una sorpresa per te» confidò papà, mentre mamma si allontanava in cucina. Riapparve qualche secondo dopo con una torta di mele, cantando Tanti auguri a te.
«Adesso il regalo!» dichiarò papà, con l’entusiasmo di un bambino, battendo le mani a ritmo.
«Chiudi gli occhi, Lucia» bisbigliò all’orecchio mia madre, Emozionata obbedii al suo ordine. «e adesso aprili.»
«Una bicicletta!» urlai riaprendoli, saltellando dalla gioia.
«Sì, tesoro. Io e papà ti insegneremo a pedalare» spiegò la mamma. «Fortunatamente oggi è sabato, significa che tornerò presto a casa e potrai provarla!»
«Grazie» mormorai, abbracciandoli.
Mamma odorava di cannella e zucchero a velo, è questo l’ultimo ricordo che conservo di lei.
Trascorsi le ore successive davanti alla finestra della cucina, da dove si poteva scorgere l’edificio dove lei lavorava.
«Oggi il cielo mi sembra più bello!» dichiarai, pensando al modo in cui avremmo trascorso il pomeriggio.
«Perché sei nata tu, amore. Per questo è più bello» s’affrettò a rispondere papà, con voce piatta.
Il cielo d’un tratto sembrò quasi triste, cupo come il viso di mio padre. Forse aveva già intuito che qualcosa di brutto stava per succedere.
«Facciamo una passeggiata, Lù» annunciò. «Vai a prendere i cappotti. Andiamo dalla mamma.»
Eravamo poco distanti dalla fabbrica, quando papà arrestò il passo.
«Cosa diavolo sta succedendo?!» urlò. Rivolse la stessa domanda più volte ai passanti, che si fermavano a osservare con stupore e orrore quel paesaggio di fumo e di fiamme. Nessuno gli fornì una risposta adeguata, erano tutti confusi a riguardo. Eccetto un uomo con uno sguardo triste che, fumando un sigaro, si avvicinò per rispondere a quella fatidica domanda. Gli disse, senza troppi giri di parole, che era scoppiato un incendio in una fabbrica: l’edificio in cui lavorava mamma stava andando a fuoco.
«Papà, dov’è la mamma?»
Non rispose. La mano che teneva serrata la mia tremava. L’altra, invece, lasciò cadere per terra la stampella e per poco papà non perse la sua stabilità.
«Papà, Papà! La mamma!» gridai, cercando di reggere il suo peso, ma ero solo una bambina di sei anni che avrebbe voluto correre dalla sua mamma.
Volavano dalla finestra come fenici: incandescenti e luminose. Ci misi un po’ a capire che a schiantarsi al suolo non erano solo vestiti fiammanti.
«Mamma, Mamma!» urlavo a perdifiato con le lacrime agli occhi, quando cominciai a capire cosa stesse succedendo.
Mia madre non sarebbe più uscita da lì, perché stava morendo in quel rogo.
Fu in quel momento che papà allentò la stretta alla mia mano e, disperato, si gettò per terra unendo i palmi delle mani in una supplichevole preghiera. Speravamo che in qualche modo si fosse messa in salvo.
E poi la riconobbi, o così mi parse. La puzza di carne bruciata era così nauseabonda da provocarmi le vertigini. Mamma era lì, sul davanzale di una finestra del quinto piano. Bellissima, con le fiamme che la coprivano come un lenzuolo. E poi la vidi crollare sul pavimento.
Gridai tra le lacrime «Mamma, mamma!», cominciando a correre verso di lei per salvarla. Ho un ricordo vago di ciò che accade dopo: papà che si precipita ad afferrarmi, lui che cerca di abbracciarmi e io che lo respingo.
«Devo andare da mamma!» urlai, cercando di scappare. «È andata» disse piano. «E quella donna poteva essere chiunque. Era troppo lontana, non avremmo mai potuto riconoscerla.»
Ormai era solo un corpo deturpato.
Era morta, e io non sapevo se si fosse gettata dalla finestra, come numerose altre donne, o se invece fosse stata schiacciata dal peso delle macerie inghiottita dal fumo.
Niente aveva senso dal momento in cui l’edificio aveva preso fuoco, cominciando a divorare come un mostro affamato le “sartine” Non aveva senso che, a pochi chilometri di distanza o dall’altra parte del mondo, nuove vite venissero alla luce e altre finissero.
Papà e io assistemmo a quella pioggia di corpi infuocati in lacrime e in silenzio. Non riuscimmo a parlare perché non c’erano parole che potessimo pronunciare.
Quel giorno mia madre non aveva perso solo la vita, ma anche un nome. Le vittime furono catalogate con dei miseri numeri. Ecco cos’era diventata mia madre: un numero a due cifre.
Non sapevo quale numero le avessero attribuito perché quei corpi non erano identificabili. Il fuoco li aveva privati dei loro connotati umani, riducendoli in cenere.
Quel 25 marzo del 1911 doveva essere un giorno indimenticabile. Lo è stato, ma non per la ragione che credevo.
Da quel giorno smisi di essere una bambina e divenni un’adulta.
Morta la mamma, papà cominciò a chiedere il mio aiuto per la casa. Posai i giocattoli in un angolo e misi il grembiule di mamma. Ancora oggi, indossandolo, mi sembra di sentire odore di cannella.
Lei era allegra, una buona madre, una brava moglie, e in pochi attimi non era più niente. Come può una vita finire così? Avevo solo sei anni e lei aveva ancora tante cose da insegnarmi.
Credo che oggi sarebbe fiera di me. Ho studiato e trovato l’amore della mia vita, con cui ho avuto due bellissimi bambini che mi hanno dato dei nipotini meravigliosi. Fa male, ma nonostante la sua assenza la vita continua a scorrere. Per questa ragione, tengo un diario: per raccontarle tutto ciò che si è persa, immaginando che le mie parole possano in qualche modo raggiungerla, e per poter conservare il suo ricordo anche per le generazioni successive.
Editing by Simona Citarrella